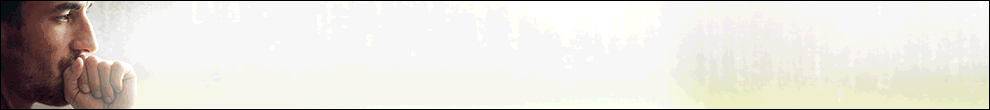Siamo alle solite. In Italia si fanno le leggi e poi, governo dopo governo, legislatura dopo legislatura, sentenza dopo sentenza, ognuno ci mette una pezza e alla fine, nemmeno dopo molto, ci si ritrova con un dettato normativo profondamente diverso rispetto a quello originario. A volte talmente tanto da tradirne addirittura lo spirito o, come dicono i più colti, la ratio legis.
La certezza che c’era… e non c’è più
Senza andare troppo lontano, è il caso delle “tutele crescenti”. Introdotte, come i più attenti ricorderanno, dal dlgs n. 23 del 4 marzo 2015 (si riferivano ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo di quell’anno), sono state fin da subito oggetto di una levata di scudi dal sapore -diciamolo- spesso più ideologizzante che realistico. Fatto sta che garantivano alle imprese almeno una certezza: quella della somma da versare in caso di licenziamento. Essendo infatti legato all’anzianità occupazionale (un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio), questo ammontare era facilmente calcolabile. Una semplificazione non da poco, oltre che una novità che si aggiungeva alla (criticatissima) riduzione delle casistiche di reintegro sul posto di lavoro.
Stravolta la ratio legis
E adesso? Ebbene, a 4 anni dalla sua nascita, il regime delle tutele crescenti si presenta già profondamente stravolto. Ha infatti dovuto passare le “forche caudine” del cosiddetto “decreto dignità” (dl 87/18, convertito in legge con la l. 96/18) e poi, sempre lo scorso anno, della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 secondo cui è incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato ancorato solo all’anzianità di servizio. Già il decreto dignità -va detto- assestava un primo, poderoso colpo all’impianto originario della legge, perché le sue modifiche hanno interessato i valori dei risarcimenti in caso di licenziamento illegittimo, e quelli di una eventuale offerta conciliativa effettuata dal datore.
La Corte Costituzionale: palla di nuovo al giudice
Soffermiamoci ora, tuttavia, sullo storico pronunciamento della Suprema Corte: secondo quest’ultima “il meccanismo di quantificazione rende infatti l’indennità “rigida” e “uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, poi 6 mensilità) e massimo (24, poi 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti”.
No a risarcimenti uniformi, l’anzianità è solo uno dei parametri
La disposizione censurata contrasta per la Corte con il principio di eguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata omologazione di situazioni diverse. Così facendo, finisce col prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, venendo meno all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch’essa imposta dal principio di eguaglianza.
Le violazioni censurate
Secondo i giudici l’articolo 3 contrasta anche con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inidoneità dell’indennità a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente. La rigida dipendenza dell’aumento dell’indennità dalla sola crescita dell’anzianità di servizio mostra la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata. La disposizione censurata viola, infine, gli articoli 76 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea, secondo cui, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impegnano a riconoscere “il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.
Nessun parametro oggettivo
In breve, la Corte Costituzionale sostiene che l’automatismo nel calcolo degli importi è illegittimo e ingiustamente “omologante”, ma “dimentica” di stabilire altri parametri oggettivi e così facendo rimette al giudice la decisione sull’ammontare del risarcimento, trasformando di fatto una somma certa in un ammontare variabile: e non di poco, visto che la medesima tipologia di recesso, prima e dopo il decreto dignità e la sentenza 194, può costare alle aziende da 30 a oltre 100 mila euro lordi (a discrezione del giudice, naturalmente). Insomma, una materia che per le imprese continua a rimanere irta di dubbi e… di rischi.
Link “decreto dignità” (87/18)
Link sentenza Corte Costituzionale 194/18